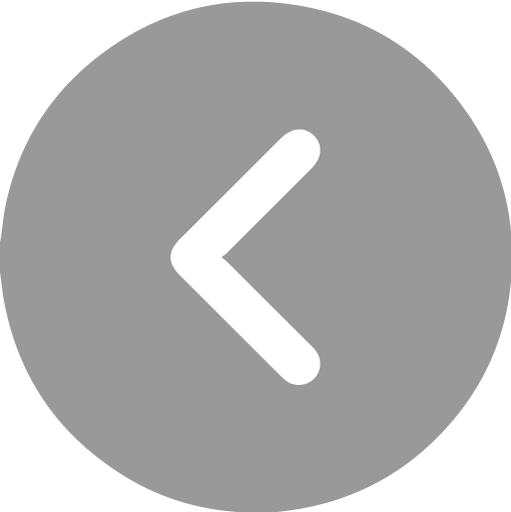Mura Greche
Le mura di Napoli sono le antiche cerchie difensive che hanno protetto per secoli la città ed i suoi abitanti.
A Napoli, essendo stata dal XVI secolo fino alla prima metà del XX secolo la città in senso proprio più popolosa della penisola, questo tipo di strutture furono oggetto di importanti demolizioni già a partire dall’epoca borbonica, per poi concludersi agli inizi del Novecento. Oggi ad ogni modo ne esistono ancora molti resti e testimonianze.
Le mura greche
Si dispongono lungo i margini del pianoro su cui sorge la città antica di Napoli ed erano protette da valloni naturali che circondavano l’abitato e costituivano dei veri e propri fossati difensivi. Queste fortificazioni avevano creato per Neapolis fama di inespugnabilità, confermataci dalle fonti storiche sia riguardo alla guerra annibalica (218-202 a.C.), sia durante il conflitto greco-gotico (VI secolo d.C.).
Provenienza dei blocchi
I blocchi venivano estratti da una vasta cava di età greca che si trova a Poggioreale; essa è stata individuata casualmente nel 1987 in séguito ad un cedimento, sotto il cimitero del Pianto, e precisamente al di sotto del piazzale antistante la chiesa di Santa Maria del Pianto. La cava, che era stata ostruita da un franamento, presenta già segnate lungo le pareti le strisce orizzontali corrispondenti all’altezza dei blocchi e – cosa ancora più sorprendente – i caratteristici segni alfabetici graffiti degli antichi cavatori. Dalla cava i blocchi venivano trasportati in città percorrendo l’attuale rettilineo di via Nuova Poggioreale – via Casanova per entrare dritti a Napoli dall’antica porta situata dove ora si trova il Castel Capuano.
Il tracciato delle mura
Il tracciato delle mura greche di Napoli – nonostante le ampie e gravi distruzioni operate nel corso dei secoli – ancora si conserva ed è riconoscibile per lunghi tratti, da essere oramai ben conosciuto nelle sue grandi linee, mentre dubbi sussistono sull’andamento in dettaglio di alcuni punti.
• Tracciato certo – Le mura si snodano lungo via Foria, piazza Cavour, rampe Maria Longo, larghetto Sant’Aniello a Caponapoli, piazzetta Sant’Andrea delle Dame, via Costantinopoli, piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, entrambi i lati di via Mezzocannone, Università, rampe di San Marcellino, via Arte della Lana e Archivio di Stato, piazza Nicola Amore, lato settentrionale di Corso Umberto, piazza Calenda, via Pietro Colletta, Castel Capuano, vico Santa Sofia, via Foria.
Tracciato incerto – Discusso è il percorso delle mura da Sant’Aniello a Caponapoli a via Mezzocannone, soprattutto il tratto da piazza Bellini a piazza San Domenico (le due piazze non sono allineate. Forse i cortili interni di San Domenico, posti obliquamente, possono suggerire l’andamento delle mura.). Pure dibattuto è il percorso di via Mezzocannone dove i resti corrono paralleli (cinema e università) forse per regolarizzare e fortificare i due lati del valloncello che, risalendo dal mare, rappresentava una via naturale di accesso alla città; intanto altri tratti di mura sono stati rinvenuti nell’area dell’Università ma in zone più interne e fanno pensare piuttosto a muri di terrazzamento.
Le porte greche
La città aveva ai due estremi dei decumani altrettante porte, generalmente del tipo “a tenaglia”:
• il decumano superiore aveva al termine occidentale porta Romana mentre all’estremo orientale porta Carbonara
• il decumano maggiore aveva al termine occidentale porta Puteolana che sorgeva presso la chiesa della Croce di Lucca e al termine orientale porta Campana accanto al Castel Capuano (poi detta porta Capuana e ricostruita nel posto dove tuttora sorge)
• il decumano inferiore infine aveva al termine occidentale porta Cumana e al termine orientale porta Furcillensis (o Herculanensis, nel Medioevo denominata del Cannavaro)
A settentrione c’era (e c’è ancora) porta San Gennaro sebbene più indietro rispetto ad oggi e del tutto diversa.
A meridione tra piazza San Domenico Maggiore e via Mezzocannone sorgeva porta Ventosa o Licinia, di cui il primo nome deriverebbe dal fatto che era esposta ai venti di scirocco, mentre il secondo deriverebbe dalla presenza, vicino alla porta, della casa di Lucio Alfio Licinio, un cittadino romano che avrebbe fatto valere i diritti della città presso il foro e il senato romano, per cui si sarebbe voluto premiare Licinio con l’intitolazione della porta a lui.'[1] Di porte meridionali dovevano essercene più d’una.
Ci sono però molti dubbi sui nomi delle antiche porte: ci sono storici come il Celano che chiamano la porta del decumano inferiore oltre che Cumana anche Puteolana. Il problema sorge anche per quanto riguarda il percorso e l’inizio della via Neapolis Puteolim per colles, la strada per mezzo della quale fu trasportato a Napoli il corpo di San Gennaro: il Celano afferma che da porta Cumana o Puteolana partiva la strada per Pozzuoli e Cuma.
Porta Cumana comunque era ubicata a piazza San Domenico Maggiore. Quando fu costruita la famosa guglia furono trovati pilastri della porta e la muratura da Francesco Antonio Picchiatti, il quale provvide a mappare i ruderi.[2]
Altre voci che affermano che a all’estremo ovest di via Tribunali non esisteva una porta sono infondate perché l’illustre archeologo Giuseppe Fiorelli afferma di aver trovato sotto la sacrestia della croce di Lucca fondamenta di una porta che ai lati aveva due torri.
Particolarmente complesse sono le aree interessate dalle antiche porte come pure dove le mura sono associate a torri (piazza Bellini, piazza San Domenico, via Mezzocannone, ecc.).
Fasi costruttive
Sono state riconosciute due fasi edilizie principali; a tali diversità corrispondono per lo più – anche se non sempre – cronologie diverse:
• La prima fase di fine VI secolo a.C. (connessa alla fondazione di Neapolis), si distingue per l’impiego di tufo grigio granuloso e per la tecnica in ortostati (ossia larghi blocchi posti di coltello su una fondazione costituita da uno o due filari di blocchi messi in piano). Possono presentare una sola cortina quando foderano il salto della collina ammorsandosi ad essa con briglie anch’esse in ortostati; oppure essere costituite da una doppia cortina rafforzata da briglie interne che creano così delle cellette riempite con scaglie di tufo (emplèkton) quando sono costruite in piano o con funzione di terrazzamento. Appartiene a questa prima fase anche il tipo di muratura “a chiave” caratterizzata da filari alterni formati da due blocchi affiancati, coperti da altri disposti di taglio.
• La seconda fase di IV secolo a.C. (da collegare alla guerra sannitica), è caratterizzata invece dall’uso di tufo giallo compatto e blocchi sistemati in assise piane. Presentano una sola cortina e briglie trasversali nella stessa tecnica, e si appoggiano alle fortificazioni di prima fase che così diventa la cortina interna. Caratteristici per i muri di seconda fase sono i segni di cava, lettere singole o nessi in alfabeto greco che furono scolpiti sui singoli blocchi durante i lavori di estrazione.
• Altre fasi – Scavi recenti hanno anche individuato rifacimenti del circuito difensivo databili al III secolo Avanti Cristo
Importanti resti
• Il Cippo a Forcella è stato scoperto nel quartiere Forcella. Questo scavo rappresenta la porta più antica e conosciuta finora ritrovata (è risalente forse al VI secolo a.C.). Benché sia una porta, è erroneamente chiamato “Cippo”, a causa della sua forma in tutto e per tutto simile a un grosso pilastro. La sua vecchiaia è addirittura entrata nel gergo popolare: quando una cosa è molto vecchia, a Napoli si usa dire “s’arricorda ‘o cipp’ a Furcella”.
• Le Mura di Piazza Bellini sono state scoperte casualmente nel 1954; altri scavi eseguiti nel 1984 nel giardinetto di fianco al monumento a Bellini furono poi reinterrati. L’attuale situazione è profondamente modificata dall’epoca greca: il piano antico era circa 10 m più in basso rispetto all’attuale, e questo tratto di mura correva lungo il ciglio di una collina ora completamente spianata, alla sommità di un vallone oggi del tutto colmato (via Costantinopoli – via San Sebastiano). Gli studiosi non sono concordi nel datare questo tratto di mura: un tempo veniva datato tutto al IV secolo a.C. considerandolo un ampliamento della cinta muraria rispetto ad una più antica rinvenuta in via del Sole; oggi lo si considera invece del V secolo a.C. rafforzato nel IV secolo a.C.; ma intanto i nuovi saggi del 1984 non hanno dato reperti anteriori al IV secolo a.C. Il problema dunque resta aperto.
• Le Mura di Piazza Cavour (alle spalle dell’edificio scolastico Salvator Rosa) sono quasi interamente di seconda fase; hanno un andamento a scarpa e fondazioni a gradoni e si conservano per un’altezza di 9,20 m. A breve distanza da esse, negli anni cinquanta fu rinvenuto in posizione arretrata un altro muro di 10 m di altezza, probabilmente di prima fase, andato distrutto per la realizzazione della Rampa Maria Longo (pochi i resti superstiti).
• Le Mura di Piazza Calenda sono costituite da grossi blocchi di tufo che formano una doppia cortina con briglie trasversali di collegamento. Sono state rinvenute durante i lavori del “Risanamento”. Le mura sono abbastanza articolate e proseguono al di sotto del manto stradale e del vicino cinema (non visibili). In effetti la piazza, non prevista nei progetti, è stata realizzata proprio per il rinvenimento delle antiche mura greche, per la tutela delle quali i costruttori dei palazzi furono obbligati dalla Soprintendenza a ridurre ed arretrare l’ingombro degli edifici.
• Le Mura di palazzo Saluzzo di Corigliano risalgono probabilmente al IV secolo e sono oggi locate nelle aule didattiche della struttura.
1. Mura Greche
2. Mura Greche
3. Mura Greche
4. Mura Greche
1. Griechische Mauern
2. Griechische Mauern
Mura Greche

Guarda LIS

Ascolta

Lettura
info e Accessibilità
Mura Greche Piazza Bellini, 80138 Napoli NA
Adatto ai bambini