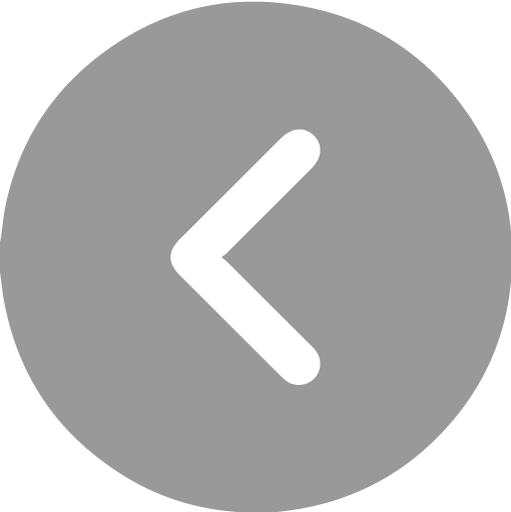Questo piccolo luogo di culto aveva in origine un’estensione ancora piú limitata. Il suo nucleo iniziale risale al 1150, come risulta da un’epigrafe posta nel vano di passaggio (ora chiuso) con l’adiacente cappella Pontano; poche tracce ne sono ancora visibili nell’arco gotico a destra dell’altare. Quell’antica struttura fu ampliata quando al suo fianco Giovanni Pontano, nell’ultimo decennio del XV secolo, fece costruire la cappella per la propria famiglia. In questa occasione le due chiesette contigue assunsero le attuali forme parallele, con l’allineamento delle facciate.

Il restauro del 1766 e successivi rifacimenti hanno conferito a questo complesso l’aspetto attuale. Fu allora messo in opera lo splendido pavimento maiolicato, datato 1775, attribuibile alla bottega della famiglia Massa. Un nuovo intervento conservativo è documentato durante il XIX secolo, quando il piccolo edificio fu concesso alla Arciconfraternita del SS. Rosario del Bambino Gesù. Dopo un lungo periodo di chiusura e di abbandono, di recente la cappella ha finalmente riacquistato agibilità e decoro. L’altare maggiore è stato ricostruito in gran parte sulla base di testimonianze certe, e sono Tra di essi sono da segnalare in primo luogo, a sinistra dell’altare, un dipinto ad olio su tre tavole di legno, raffigurante la Crocifissione tra i Santi Carlo Magno e Luigi di Francia, che ha un alto valore storico e simbolico, il cui significato richiede almeno alcune indicazioni specifiche. Inoltre, sull’altare maggiore, è collocata la Trasfigurazione di Cristo, del pittore Giuseppe Marullo e a destra la Madonna del Rosario, firmata e datata 1805 dal pittore Francesco Gagliano. Le peculiarità stilistiche della Crocifissione tra santi, celate sotto gli strati di pittura che le alteravano, sono riemerse in seguito ad un lungo e sapiente restauro.
Crocifissione tra Santi
Per le figure rappresentate e per i particolari simbolici che vi sono posti in forte evidenza la Crocifissione presenta grande interesse storico, perché fu eseguita in chiaro rapporto con la spedizione francese diretta alla riconquista del Regno di Napoli contro gli ‘usurpatori’ aragonesi. Questo fu un avvenimento apparentemente militare e dinastico, ma è indicativo della svolta epocale (1494-1495) avvenuta proprio quando fu costruita la cappella Pontano, al cui abbellimento la Crocifissione fu probabilmente destinata. Il crollo della dinastia aragonese fu il segno di una drammatica transizione dagli smembrati assetti principeschi (le cui strutture mostravano indipendenze politiche molto precarie ), ai secoli tristi delle soggezioni alle potenze straniere, oltre trecentosessanta anni durante i quali, prima dell’Unificazione nazionale, l’Italia fu percorsa, dominata e prostrata, come aveva previsto Machiavelli, da quanti se ne contesero il possesso.

La campagna militare realizzata nell’estate-autunno del 1494 dal giovane re di Francia Carlo VIII (1470-1498), duca d’Angiò, fino al 22 febbraio 1495, giorno della sua entrata in Napoli, aveva richiesto lunga preparazione ed un’ampia raccolta di capitali, presi in prestito anche da banchieri fiorentini. Il re disponeva di un potente esercito, di un’abbondante ed agguerrita cavalleria e di un’artiglieria leggiera, mobile, molto progredita. I francesi godevano di una condizione di superiorità incomparabile, non solo numerica e tecnica, ma perché erano comandati da una nobiltà di spada fortemente motivata, disposta a qualunque sacrificio negli interessi della monarchia, simbolo di una patria già da mezzo millennio unita. Giovanni Pontano, che era consigliere della corte aragonese, definí il re di Francia «il maior Re del Mondo», in una lettera diretta al suo sovrano, Ferdinando II, detto Fernandino. Questi aveva proprio allora ereditato il trono di Napoli perché il padre, Alfonso II di Aragona, aveva abdicato a suo favore e si era imbarcato, il 4 febbraio 1495, per rifugiarsi in Sicilia. Quella ritirata avvenne appena il re ebbe notizia che i due Borgia, Rodrigo (papa Alessandro VI) ed il figlio Cesare, fino ad allora suoi alleati, si erano schierati a favore di Carlo VIII. È implicita nel dipinto la contrapposizione tra due opposti modelli di organizzazione statale: il francese, efficiente, moderno, vincente, ed il subalpino, ambigua espressione del passato.
Il crollo coinvolse in modo diretto o indiretto le popolazioni dell’intera Italia, che erano da tempo incapaci di competere sul piano internazionale. In quell’occasione i roboanti proclami di guerra e di resistenza all’ultimo sangue, diffusi da molti tra i principi italiani, si trasformarono subito in indecorosi atti di sottomissione appena comparve ai confini l’esercito invasore. La campagna militare francese vinse senza combattere. Fece scandalo in tutt’Europa che le strutture politiche locali si dimostrarono innanzi tutto mancanti del benché minimo fattore di coesione intorno ad ideali ed interessi comuni. Proprio i simboli di quell’unità spirituale, in Italia assente, sono ritratti nella Crocifissione. L’intento encomiastico a favore del modello francese ha un chiaro significato allusivo alla debolezza strutturale della cultura sociale subalpina, che poi per secoli non poté superare quei limiti, già allora evidenti.
Il polittico raffigura questa situazione mediante l’enfasi della santità, della compattezza ideale e politica del regno di Francia, e quindi della sua missione universale, indicata attraverso immagini relative all’ultima fase della sua storia millenaria, dal secolo nono (Carlo Magno) al tredicesimo (Luigi IX), di cui Carlo VIII era discendente. I simboli di quell’idealità patriottica, i gigli di Francia (che indicano la Trinità come pura, autentica saggezza) sono impressi in grande evidenza sugli abiti dei due re, Carlo Magno e Luigi IX, indicati come difensori della Croce, secondo un’iconografia apologetica che fu tipica della monarchia francese. I re (da Saint Clovis in poi) erano dotati di aureola intorno al capo e santificati in modo del tutto autonomo rispetto ai complessi processi canonici richiesti dalle regole pontificie. Il modello cui s’ispirò la Crocifissione fu quasi certamente un trittico piú ampio, dipinto tra il 1455 e il 1460, esistente nel parlamento di Parigi, oggi al museo del Louvre, in cui figurano immagini molto simili dei due re, ma mancanti di aureola. In entrambi i dipinti all’interno del manto di Carlo Magno sono impresse le aquile imperiali, ed egli regge in una mano la spada e nell’altra il globo, simbolo del potere universale, sacro e profano. Come spesso avveniva, il volto di Luigi IX il santo ha i lineamenti di un altro re, qui probabilmente di Filippo IV il Bello.
La contrapposizione poneva di fronte lo smembramento istituzionale, politico e sociale subalpino, dove i modesti principati non erano in grado neanche di contrapporsi all’eccellente forza specialmente ideale della nazione francese. La consistenza attuale dell’opera pare che sia solo la parte superstite di un polittico a piú registri,di autore ignoto, eseguito in stretto rapporto alla spedizione di Carlo VIII.
1. origini
2. restauro
3. CROCIFISSIONE TRA SANTI
1. origins
2. restoration
3. crucifixion between saints
Cappella del SS. Salvatore

Guarda LIS

Ascolta

Lettura
info e Accessibilità
Piazzetta Pietrasanta, 80138 Napoli NA
0815571365
Ingresso in sedia a rotelle
orari apertura
| Giorni | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 10:00 | 19:00 |
| Martedì | 10:00 | 19:00 |
| Mercoledì | 10:00 | 19:00 |
| Giovedì | 10:00 | 19:00 |
| Venerdì | 10:00 | 19:00 |
| Sabato | 10:00 | 19:00 |
| Domenica | 10:00 | 19:00 |