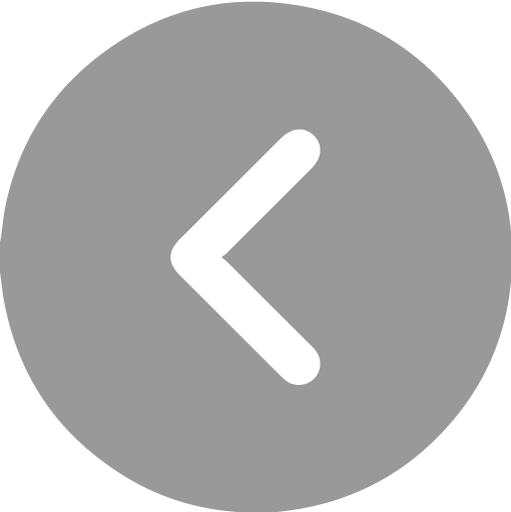Maschio Angioino
Castel Nuovo, o più comunemente Maschio Angioino (anche Mastio Angioino), è uno storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di Napoli.
Il castello domina la scenografica piazza Municipio ed è sede della Società napoletana di storia patria e del comitato di Napoli dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, ospitato nei locali della SNSP. Nel complesso è situato anche il Museo civico, cui appartengono la cappella Palatina e i percorsi museali del primo e secondo piano. La Fondazione Valenzi vi ha la sua sede di rappresentanza, inaugurata il 15 novembre 2009 dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed altre autorità, nell’ambito della celebrazione dei cento anni dalla nascita di Maurizio Valenzi.
Le origini e il periodo angioino
La costruzione del suo nucleo antico – oggi in parte riemerso in seguito ad interventi di restauro ed esplorazione archeologica – si deve all’iniziativa di Carlo I d’Angiò, che nel 1266, sconfitti gli Svevi, salì al trono di Sicilia e stabilì il trasferimento della capitale da Palermo alla città partenopea.
La presenza di una monarchia esterna aveva impostato l’urbanistica di Napoli intorno al centro del potere regale, costituendo un polo urbanistico alternativo, formato dal porto e dai due principali castelli ad esso adiacenti, Castel Capuano e Castel dell’Ovo. Tale rapporto tra corte regale e urbanistica cittadina si era manifestato già con Federico II, che nel XIII secolo, nello statuto svevo aveva concentrato le maggiori attenzioni sui castelli trascurando affatto le mura cittadine. Ai due castelli esistenti gli Angioini aggiunsero il principale, Castel Nuovo (Chastiau neuf), che fu non solo fortificazione ma soprattutto la loro grandiosa reggia.
La residenza reale di Napoli era stata fino ad allora Castel Capuano, ma l’antica fortezza normanna venne giudicata inadeguata alla funzione e il re volle edificare un nuovo castello in prossimità del mare.
Bifora gotica-angioina del XIV secolo presente sotto la volta del XV secolo
Assegnato il progetto all’architetto francese Pierre de Chaule, i lavori per la costruzione del Castrum Novum presero il via nel 1279 per terminare appena tre anni dopo, un tempo brevissimo viste le tecniche di costruzione dell’epoca e la mole complessiva dell’opera. Il re tuttavia non vi dimorò mai: in seguito alla rivolta dei Vespri siciliani, che costò all’Angioino la corona di Sicilia, conquistata da Pietro III d’Aragona e ad altre vicende, la nuova reggia rimase inutilizzata fino al 1285, anno della morte di Carlo I.
Affresco eseguito da Raimondo del Balzo nel castello in età angioina, XIV secolo
Il nuovo re Carlo II lo Zoppo si trasferì con la famiglia e la corte presso la nuova residenza, che fu da lui ampliata e abbellita. Durante il suo regno la Santa Sede fu particolarmente legata alla casa d’Angiò, in un rapporto turbolento, che anche negli anni successivi sarà scandito da pressioni, alleanze e rotture continue. Il 13 dicembre del 1294 la sala maggiore di Castel Nuovo fu teatro della celebre abdicazione di papa Celestino V, l’eremita Pietro da Morrone, dal trono pontificio, colui che fece, secondo Dante il gran rifiuto e il 24 dicembre successivo, nella stessa sala il collegio dei cardinali elesse pontefice Benedetto Caetani, che assunse il nome di Bonifacio VIII e trasferì immediatamente la sua sede a Roma per sottrarsi alle ingerenze della casata angioina.
Personaggi che hanno soggiornato nel castello
Il Maschio Angioino, nel corso della sua storia, è stato utilizzato più volte come residenza temporanea per ospitare illustri personaggi recatisi a Napoli ospiti della corte reale o in visita ufficiale.
Tra le principali personalità che hanno visitato il castello nel XIV secolo si annoverano:
Giovanni Boccaccio
Giotto
Papa Bonifacio VIII
Papa Celestino V
Francesco Petrarca
Jean Fouquet
Giovanni Pontano
Lorenzo Valla
Guillem Sagrera
Con l’ascesa al trono di Roberto il Saggio, nel 1309, il castello, da lui ristrutturato e ampliato, divenne un notevole centro di cultura, grazie al suo mecenatismo e alla sua passione per le arti e le lettere: Castel Nuovo ospitò importanti personalità della cultura del tempo, come i letterati Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio nelle loro permanenze napoletane, mentre i più famosi pittori dell’epoca vennero chiamati ad affrescarne le pareti: Pietro Cavallini, Montano d’Arezzo, e soprattutto Giotto, che nel 1332, venne qui chiamato per la cappella Palatina.
Volta gotica, risalente al XV secolo, dove sono visibili lo stemma aragonese, il libro di luce e altri simboli esoterici risalenti al periodo di Alfonso il Magnanimo
Dal 1343 fu dimora di Giovanna I, che nel 1347, in fuga verso la Francia, lo abbandonò agli assalti dell’esercito del re d’Ungheria Luigi I il Grande. Questi era giunto a vendicare la morte del fratello Andrea, il marito di Giovanna, ucciso da una congiura di palazzo che la stessa regina fu sospettata aver istigato. Il castello venne saccheggiato e al suo ritorno la regina fu costretta ad una radicale ristrutturazione. Durante la seconda spedizione di Luigi contro Napoli il castello, dove la regina aveva trovato rifugio, resistette agli assalti. Negli anni successivi la fortezza subì altri attacchi: in occasione della presa di Napoli da parte di Carlo III di Durazzo e successivamente di quella di Luigi II d’Angiò, che la sottrasse al figlio di Carlo III, Ladislao I. Quest’ultimo, riconquistato il trono nel 1399, vi abitò fino alla morte, nel 1414.
Giovanna II successe al fratello Ladislao e ascese al trono come ultima sovrana angioina. La regina, dipinta come una donna dissoluta, lussuriosa, sanguinaria, avrebbe ospitato nella sua alcova amanti di ogni genere ed estrazione sociale, addirittura rastrellati dai suoi emissari fra i giovani popolani di bell’aspetto. Per tutelare il suo buon nome, Giovanna non avrebbe esitato a disfarsi di loro appena soddisfatte le sue voglie. Proprio a questo proposito si è narrato per secoli che la regina disponesse, all’interno del castello, di una botola segreta: i suoi amanti, esaurito il loro compito, venivano gettati in questo pozzo e divorati da mostri marini. Secondo una leggenda sarebbe stato addirittura un coccodrillo, giunto dall’Africa fino ai sotterranei del castello dopo aver attraversato il Mediterraneo, l’artefice dell’orrenda morte degli amanti di Giovanna.
Torre del Beverello. Nel XV secolo la torre presentava al primo piano una finestra guelfa, mentre al secondo piano una monofora ogivale (ad arco acuto), ancora parzialmente visibile
Portale bronzeo di Castel Nuovo
Gli Aragonesi
Alfonso d’Aragona, che aveva conquistato il trono di Napoli nel 1443, volle stabilire nel castello la funzione di centro del potere regale e una corte di magnificenza tale da competere con quella fiorentina di Lorenzo il Magnifico. La fortezza venne completamente ricostruita nelle forme attuali. Re Alfonso affidò la ristrutturazione della vecchia reggia-fortezza angioina ad un architetto aragonese, Guillem Sagrera, catalano originario di Maiorca, che la concepì in termini gotico-catalani.
Il castello visto dalla strada.
Le cinque torri rotonde, quattro delle quali inglobavano le precedenti torri angioine a pianta quadrata, più adatte a sostenere i colpi delle bocche da fuoco dell’epoca, ribadivano il ruolo difensivo del castello. L’importanza dell’edificio come centro del potere regale venne invece sottolineata dall’inserimento in corrispondenza del suo ingresso dell’arco trionfale, capolavoro del Rinascimento napoletano ed opera di Francesco Laurana oltre a molti artisti di varia provenienza. I lavori si svolsero a partire dal 1453 e si conclusero solo nel 1479, dopo la morte del re.
Nella “sala dei Baroni” si svolse nel 1487 l’epilogo della famosa congiura dei baroni ordita contro re Ferdinando I, figlio di Alfonso, da numerosi nobili, capeggiati da Antonello II di Sanseverino, principe di Salerno, e da Francesco Coppola, conte di Sarno. Il re invitò tutti i congiurati in questa sala col pretesto di una festa di nozze che segnasse il superamento delle ostilità e la definitiva riconciliazione. I baroni accorsero, ma il re, dopo aver ordinato ai suoi soldati di sbarrare le porte, li fece arrestare tutti, punendo molti di loro, fra cui il Coppola e i suoi figli, con la condanna a morte. Nella metà del secolo il castello fu immortalato nella celebre Tavola Strozzi, e più tardi anche nella Cronaca figurata del ‘400 che descrive l’inizio delle disastrose guerre d’Italia.
Raffigurazione del Castel Nuovo (Maschio Angioino) intorno al 1470 al massimo del suo splendore. Particolare della Tavola Strozzi, che raffigura Napoli nel XV secolo.
Sul finire del XV secolo al castello fu aggiunta alla torre del Beverello un’altra finestra crociata che sostituì la precedente bifora posta al terzo piano della torre.
Il vicereame e l’inizio della decadenza di Castel Nuovo
Il castello venne nuovamente saccheggiato ad opera di Carlo VIII di Francia, nel corso della sua spedizione del 1494. Con la caduta di Ferdinando II prima (1496) e di Federico I in seguito (1503), il regno di Napoli venne annesso alla corona di Spagna da Ferdinando il Cattolico, che lo costituì in vicereame. Castel Nuovo perse la funzione di residenza reale, diventando un semplice presidio militare a motivo della sua posizione strategicamente importante; durante il lungo periodo del vicereame il castello subì vari danni perdendo gran parte degli ornamenti esterni in gotico fiammeggiante e in stile rinascimentale.
Tra i maggiori danni della metà del XVI secolo e di tutto il XVIII secolo quello più evidente è stata la sostituzione delle finestre francesi angioine realizzate in pietra e a croce (finestre guelfe), con scarne finestre di muratura e contornate secondo il gusto seicentesco da un riquadro grigio. La cancellazione del passato angioino e poi aragonese non era dettato dai soli motivi di funzionalità (nel Seicento era una prigione), ma anche da motivi politici: i nuovi dominatori spagnoli dovevano cancellare sia il ricordo di Napoli angioina che quella aragonese e per farlo era necessario anche abbatterne o modificarne gli ornamenti. Questo fu durante la dominazione spagnola in Italia (non solo a Napoli) una prassi. Per fare un altro esempio anche il monastero gotico di Santa Chiara subì la medesima sorte. Il castello nel XVI secolo ospitava ancora raramente i re di Spagna che giungevano in visita a Napoli, come lo stesso imperatore Carlo V, che vi abitò per un breve periodo nel 1535.
Il cortile del Castello dove oltre la cappella è visibile il padiglione modificato nel Seicento
Sala dei Baroni, dove si nota la volta a crociera realizzata in tufo bianco in gotico fiammeggiante
Tra i più deleteri interventi che furono realizzati durante il vicereame spagnolo fu la cancellazione di ben quattro affreschi di Giotto (realizzati nel ‘300) che decoravano la cappella Palatina. Oltre alla mano dell’uomo anche l’incuria impoverì il castello di molti stucchi e decorazioni. Nel XX secolo per un incendio scoppiato nella sala dei Baroni andarono perduti altri dipinti eseguiti da Giotto.
Nel corso del periodo vicereale, dopo la realizzazione dei bastioni poligonali che circondarono il castello, l’area tra il castello e i bastioni vicereali divenne vittima di abusivismi edili, alloggi improvvisati ecc. Tutto ciò segnò l’inizio del declino del castello, costretto a non respirare più per secoli e in seguito completamente coperto da edifici e capannoni di varia natura.
I Borbone di Napoli
Castel Nuovo dopo gli interventi di recupero nel 1823
Il castello venne nuovamente sistemato da Carlo di Borbone, futuro Carlo III di Spagna, salito al trono di Napoli nel 1734, il quale sostituì la caotica facciata del lato est (ormai le superfetazioni di età vicereale avevano totalmente stravolto l’aspetto del castello) con un casermone di cinque piani, coperto da un tetto a spiovente, forse mansardati, come nello stile degli edifici borbonici allora in voga. Il castello perdette tuttavia il suo ruolo di residenza reale, in favore delle nuove regge che si andarono edificando nella stessa Napoli e nei suoi dintorni (il Palazzo reale di piazza del Plebiscito, la Reggia di Capodimonte, la Villa reale di Portici e la Reggia di Caserta) e divenne essenzialmente un simbolo della storia e della grandezza di Napoli. Un altro intervento vi fu nel 1823 ad opera di Ferdinando I delle Due Sicilie, che però riguardò solo la facciata nord che affacciava a mare del castello, vennero recuperate le finestre crociate in forte stato di degrado e si tentò di recuperare la facciata al mare della cappella Palatina. Questi interventi furono immortalati in una stampa francese del 1855.
L’ultimo evento importante risale al 1799, quando vi fu proclamata la nascita della Repubblica Partenopea. In seguito ospitò l’”arsenale di artiglieria” e un “officio pirotecnico” che nel 1837 si stimò più prudente trasferire nella Real Fabbrica d’Armi di Torre Annunziata.
Seppur furono ben due gli interventi per recuperare il castello in età borbonica, si deve aggiungere che furono interventi con dei loro limiti (non esisteva ancora una teoria completa del restauro) e che non riuscirono a salvare il castello dalla continua crescita abusivista che coinvolse Napoli tra il periodo vicereale fino al primo dopoguerra.
Dal primo dopoguerra ad oggi
Facciata del Castello prima del restauro del XX secolo
Il nuovo secolo ereditò un castello in forte stato di degrado, le facciate esterne erano state completamente inglobate tra i residui delle casematte vicereali, fabbricati ed altri edifici sorti tra la fine del XVII secolo e la fine del XVIII secolo. Le merlature erano pressoché sparite e le finestre del XIV e XV secolo erano state rimaneggiate fino a perdere qualsiasi caratteristica medievale e rinascimentale. Ciò che caratterizzava il castello erano dunque degrado e abbandono. Agli inizi del Novecento si decise quindi di recuperare il castello, liberarlo dagli abusivismi e dai capannoni e farlo tornare, almeno per quanto riguarda le facciate esterne al XV secolo; la documentazione iconografica di riferimento furono la Tavola Strozzi, le miniature del Ferraiolo (fine XV secolo) e le raffigurazioni del golfo di Napoli agli inizi del XVI secolo. Agli inizi del Novecento vennero abbattuti tutti gli edifici sorti ammassati sul castello, recuperando un ampio spazio e facendo tornare a vista le antiche mura medievali. Fu abbattuto l’ala-caserma voluta sotto i Borbone e riemersero anche qui le mura quattrocentesche. Ottenuto finalmente dallo Stato l’intero castello a scopi civili, i lavori cominciarono nel 1923 e interessarono anche le fabbriche e i capannoni costruiti a ridosso della piazza in luogo dei demoliti bastioni: già l’anno successivo tutti i vari edifici furono eliminati e fu creata la spianata dove furono realizzati dei giardini sul lato dell’odierna via Vittorio Emanuele III.
Castel Nuovo alla fine del XIX secolo
Entrata del Castello negli anni ’40 durante il restauro e il recupero degli spazi
Negli anni Venti fu realizzata l’ampia fascia di aiuole che costeggiò il Maschio Angioino fino alla fine del XX secolo: nei primi mesi del 1921 il conte Pietro Municchi, ingegnere allora assessore al decoro urbano, presentò al Consiglio Comunale la proposta dell’isolamento del Castel Nuovo. Fu risparmiata soltanto la porta della Cittadella, l’originario accesso aragonese al complesso, rifatto nel 1496 da Federico d’Aragona (come testimonia il suo stemma presente sull’arco): isolata e snaturata della sua funzione, è visibile tra le aiuole squadrate lungo via Vittorio Emanuele III. I lavori relativi al restauro del castello, che eliminarono le molte superfetazioni aggiunte nel tempo, durarono fino al 1939. Durante questi lavori furono necessari anche dei lavori di ripulitura e restauro che eliminarono gli edifici sorti fra XVII e XIX secolo a ridosso del castello e riuscirono a restituire al castello parte del suo stile ormai perduto; tuttavia, dato la disastrata condizione dei tetti e delle tegole (sull’ala Don Pedro de Toledo e sulla cappella Palatina e la sala dei Baroni), fu necessario rimuovere le coperture. Ciò nonostante non furono mai ricostruiti i tetti a falde e negli anni ’70 si preferì poi ricoprire il “terrazzo” con la guaina, creando un effetto fortemente antiestetico e antistorico oltre che antifunzionale. Negli anni ’40 il castello appariva all’esterno in stile totalmente medievale, furono riaperte le finestre crociate murate, le merlature erano state recuperate. Sebbene lodevoli questa campagna di restauri non riuscì a recuperare lo stile angioino e aragonese anche nel cortile interno. Difatti ben due facciate (ala sud e ala ovest) risalgono al XVII secolo, la facciata est al 1535, mentre l’unica ala quattrocentesca rimasta sarebbe quella nord, con l’ingresso della cappella Palatina e la scalinata che da alla Sala dei Baroni. Oggi il castello presenta problemi di natura statica all’ingresso, non è possibile camminare lungo le merlature bastionate che circondano le torri, e molte sale e persino le torri restano chiuse al pubblico; il problema maggiore va ricercato nella mancata manutenzione che separa il dopoguerra (segnato da una straordinaria, quanto però incompleta, visto anche il progetto faraonico, opera di restauro) dai giorni odierni, dove la mancata manutenzione dei 70 anni appena trascorsi, sommato a delle revisioni che andrebbero fatte, rendono il restauro del castello simbolo della città e della sua storia urgente.
Descrizione
Della fortezza angioina rimane la cappella Palatina, alcune torri e le mura e le finestre a croce francesi accanto alla cappella.
Il castello in parte ricostruito da Alfonso d’Aragona si presenta di pianta irregolarmente trapezoidale ed era difeso da cinque grandi torri cilindriche, quattro rivestite di piperno e una in tufo, e coronate da merli su beccatelli. Le tre torri sul lato rivolto verso terra, dove si trova l’ingresso, sono le torri “di San Giorgio”, “di Mezzo” (che crollò alle ore 11:30 del 4 agosto 1876) e “di Guardia” (da sinistra a destra), mentre le due sul lato rivolto verso il mare prendono il nome di torre “dell’Oro” e di torre “di Beverello” (ancora da sinistra a destra). Il castello è circondato da un fossato e le torri si elevano su grandi basamenti a scarpata, nei quali la tessitura dei blocchi in pietra assume disegni complessi, richiamando esempi catalani.
La scala catalana (Torre Beverello)
La scala interna ad ognuna delle torri, è chiamata volgarmente scala catalana. La stessa porta sul tetto del castello, dove in passato venivano poste le vedette di guardia per controllare dall’alto un eventuale arrivo dei nemici.
Sul lato settentrionale si apre, presso la torre “di Beverello”, una delle finestre crociate della Sala dei Baroni; mentre altre due finestre si affacciano sul lato orientale, una verso il mare e l’altra, lungo la parete di fondo della Cappella Palatina, con monofora tra due strette torri poligonali. Protetto dall’altra torre angolare detta “dell’Oro”, segue poi un corpo di fabbrica avanzato che, in origine, sosteneva una loggia e un tratto rientrante con due logge sovrapposte.
Sul lato meridionale, di fronte al Molo Beverello, si sovrappone infine un lungo loggiato.
1. maschio angioino
2. maschio angioino
3. maschio angioino
1. Angevin-Männchen
2. Angevin-Männchen
3. Angevin-Männchen
1. maschio angioino
2. maschio angioino
3. maschio angioino
Maschio Angioino

Guarda LIS

Ascolta

Lettura
info e Accessibilità
Via Vittorio Emanuele III, 80133 Napoli NA
0817957722
Ingresso accessibile in sedia a rotelle
Prcheggio accessibile in sedia a rotelle